Disfunzione erettile. Vademecum d’azione
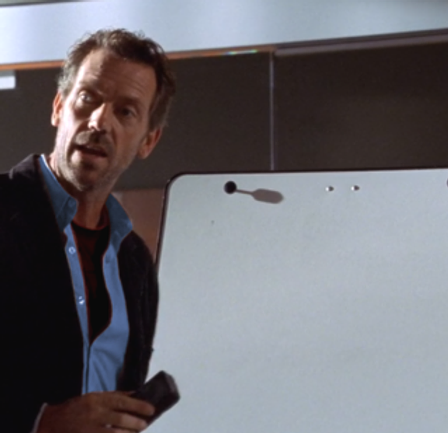
Per poter affrontare un problema estremamente diversificato come la disfunzione erettile, è importante comprendere quali ne siano i meccanismi psicologici sottostanti per ogni uomo.
In questo articolo non prenderemo in considerazione le disfunzioni erettili causate da problemi organici (malattie, assunzione di farmaci o sostanze); se siete interessati all’argomento, rivolgetevi ad un professionista di riferimento.
Le cause psicologiche della disfunzione erettile
La disfunzione erettile sostenuta da una causa psicogena si manifesta generalmente in pazienti giovani, ha un inizio brusco e non graduale, si presenta in forma circostanziata (cioè in alcune situazioni ma non in altre) ed è spesso associata ad altre forme di disagio psicologico.
Il problema di fondo più comune riscontrato è l’ansia da prestazione, un timore del fallimento e di non deludere associato ad una sensazione di inadeguatezza. L’ansia da prestazione tende a contrastare la partecipazione erotica all’azione sessuale e il potersi lasciare andare alle sensazioni eccitatorie. Questi uomini sono spesso eccessivamente preoccupati dal risultato dell’atto sessuale, finendo per sottovalutare l’importanza della partecipazione emozionale.








